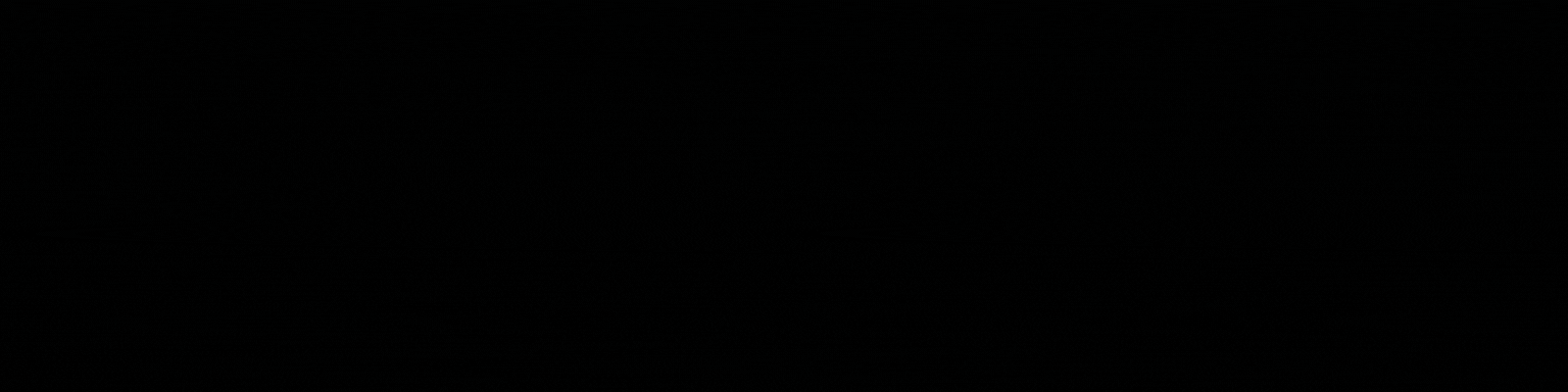di Silvana Picardi
Che strana la richiesta di dover scrivere una pagina di vita.
< Una sola pagina? > mi son detta.
< Io di pagine già ne ho scritto un centinaio e forse più > ho risposto al mio terapeuta.
Ho ricordato così le numerose pagine scritte l’estate scorsa, quando la vista di quella coreografia cilentana e quelle stelle splendenti sul bel monte rievocavano alla mia mente le luci scintillanti del mio dolce Natale, le felici estati con i miei fratelli, gli sguardi silenti di mia madre.
Una cosa però ho dimenticato di scrivere: i miei giochi, i giochi che facevo con le mie amichette.
Mi rivedo bambina, non ho le trecce, non volevo che la mamma me le facesse. Mi piaceva essere pettinata con la coda di cavallo che sventolava al vento quando correvo e saltavo. Quel fruscio, talvolta pungente, mi carezzava la pelle, faceva dondolare i miei pensieri, mi portava lontana con la fantasia. Strano che quella semplice pettinatura mi provocasse tutto questo. Eppure quando giocavo, sentivo che mi dava il ritmo giusto per far muovere le mie gambe. Su e giù quando saltavo con la corda o giocavo a campana; sinistra e destra quando correvo o giocavo con la palla.
Con la palla, quando ero sola, mi esercitavo giocando sul muro. Recitavo l’abituale filastrocca, toccavo le varie parti del corpo e contemporaneamente lanciavo la palla verso il muro.
Era bello allenarmi, in tal modo quando avrei giocato con le amichette, avrei avuto la possibilità di arrivare allo stadio finale dove bisognava girare intorno a sé. Fatto è che io quell’ultimo movimento lo sapevo fare bene, non sbagliavo mai quando facevo le prove forse perché la coda di cavallo mi dava lo slancio. Sbagliavo, invece, quando dovevo toccare terra. Probabilmente guardavo a terra e non osservavo la palla che stava tornando indietro. Ricordo però che col tempo capii che dovevo toccare il suolo senza abbassare lo sguardo.
Col tempo ho capito anche che, all’ultima fase del gioco, riuscivo a prendere sempre la palla perché mi allontanavo dal muro creando una distanza più lunga che mi dava la possibilità di girare e riprendere la palla.
Ecco, ora capisco perché le amichette mi dicevano di stare sempre allo stesso posto e di non spostarmi. Ed ecco perché poi mettemmo regole per avere tutte la stessa possibilità di vincere.
Al gioco della campana partecipavamo in cinque o sei di noi. Disegnavamo insieme lo schema sul marciapiede, procuravamo un sasso piatto e ci divertivamo da morire.
Che bello i giochi all’aria aperta!
Si rideva. Imparavamo a stare insieme. Cadenzavamo il ritmo e il movimento, imparavamo a contare, a cantare, a memorizzare, a stare insieme con i più grandi e i più piccini.
Quando eravamo in molti, giocavamo all’Angelo e il Diavolo. Facevamo la conta e un Angelo si disponeva di fronte al gruppo di bambini poi, li chiamava e questi dovevano correre per raggiungerlo. Il Diavolo, invece, si disponeva lateralmente per colpire il bambino con una palla, catturarlo e impedirgli di correre dall’Angelo.
Il bambino scrutava la situazione e correva verso l’Angelo per salvarsi. Se il Diavolo, dalla sua postazione lo colpiva con una palla, realizzata con carta accartocciata, doveva far parte del gruppo dei cattivi. A noi bambini faceva piacere che vincesse l’Angelo perché eravamo riusciti a difenderci dalle tentazioni del diavolo; saremmo stati protetti dall’Angelo Custode e avremmo fatto parte del gruppetto dei buoni.
Solo da grande ho dato un valore diverso alle nostre azioni. Da piccoli, quando succedeva qualcosa, era sempre colpa di quel diavoletto tutto rosso con la bocca digrignata e il forcone innalzato, che ci faceva comportare male e quando facevamo una buona azione, l’Angelo ricciolino sorrideva.
Nelle pagine del libro di lettura che puntualmente leggevamo, c’erano costanti riferimenti sul valore del perdono, il sacrificio, il risparmio e l’importanza della patria.
Appartenevamo a quella generazione che ci ha visti giocare per strada. Certo i tempi sono cambiati, sarebbe impensabile oggi, a parte l’impeto irrefrenabile dei ragazzini di oggi di fare uso e abuso dei mezzi tecnologici, giocare per strada. Ai miei tempi non c’erano tante macchine e se c’erano, non correvano all’impazzata per le strade pubbliche. Sui marciapiedi, ben puliti dallo spazzino rionale, non c’erano cacche di cani né cicche di sigarette per cui noi facevamo la nostra bella campana, giocavamo a nascondino, correvamo e giocavamo.
A me piaceva giocare di più con la corda. Non ero troppo veloce a correre, perdevo sempre e spesso mi trovavo a stare dalla parte del diavolo. I giochi che mi piacevano più di tutti erano due: uno, per così dire, sedentario e uno movimentato.
Quando capitava che qualche vicino ci sgridasse perché eravamo troppi e facevamo confusione, la mia mamma, per non creare disagi col vicinato, con voce suadente m’invitava a fare un gioco che impegnava anche se stessa.
< Nenè, vieni dentro, ti faccio fare la cucinetta > mi diceva.
Io, luminosa in viso e raggiante di gioia, rientravo frettolosa con la gioia nel cuore. Invitavo due o tre amichette, che andavano a chiedere il permesso alle loro mamme e, dopo aver procurato qualcosa di buono venivano a casa mia. La mamma, nel frattempo, tagliava le patate. Io la guardavo sott’occhi felice nel vederla dedicarsi completamente a me. Appena ci vedeva riunite, ci dava una grossa coperta, quella militare grigia scura e pungente con le strisce bianche sul fondo. Noi la mettevamo sul tavolo facendola scivolare lungo i lati per formare una capanna. Sotto la capanna, ovvero sotto al tavolo, la mamma ci dava un telo più morbido e dei cuscini. Noi andavamo avanti e indietro per prendere i piattini e tutto quello che serviva per fare il picnik nella nostra accogliente capannella.
Accartocciate in quell’area protettiva, ovattata e racchiusa come un grembo materno, che belle cose raccontavamo!
Parlavamo di scuola, delle maestre, dei compiti, inventavamo nuovi giochi. Quando avevamo più tempo a disposizione, giocavamo al gioco dei nomi, fiori e città oppure a dama se eravamo solo due.
Poche volte eravamo in due e poche volte eravamo in troppe durante i nostri giochi. In media eravamo in sei o sette. Cerco di ricordare: Anna del falegname, Anna del sarto, Anna del giornalaio, Annarella ed io. Ricordo queste in particolare. Che strano, tutte si chiamavano Anna!
La mia vita è stata circondata e coronata da amiche che si chiamano Anna. Attualmente, infatti, ne ho tre, forse quattro, ma con quest’ultima, con la quale condividevo le patatine fritte di mamma non ci vediamo più. È presente, comunque nel mio cuore e nei miei pensieri. Ricordo, infatti, e le immagini si susseguono davanti ai miei occhi, quando giocavamo con la corda.
Anche lei era brava. Era brava in tante cose e soprattutto era svelta. Già e come non poteva esserlo? La sua mamma non le dava tregua, la comandava, a bacchetta come siamo soliti dire noi del sud. Lei ubbidiva, doveva obbedire.
< Anna, muoviti, vai a comprare i panini. Anna sbrigati, vai a riordinare. Anna svelta metti a posto la stanza…>
C’era sempre qualcosa che doveva fare. Qualcosa che le impediva pienamente di giocare tutto il tempo in cui noi altre ci trastullavamo prima di eseguire i compiti. Ma lei, la mia Anna, la figlia del sarto, non doveva e non poteva svagarsi prima di studiare.
I compiti per lei, anzi per la sua mamma, erano l’ultima cosa. Se aveva tempo di farli bene, altrimenti poco importava se non sapesse verbi, tabelline e non leggesse a sufficienza. La mia mamma, al contrario, dopo aver giocato mi faceva sedere di fronte a lei e mi faceva ripetere tutto. La sento ancora nelle orecchie con quelle asfissianti ripetizioni di verbi e tabelline che, a dire la verità faccio anch’io con mio nipote, ma senza esagerare.
Quando Anna, sempre Anna del sarto, quel sarto amabile che io ammiravo perché era l’unico a difendere la mia amica, divenne adolescente, la mamma subito le trovò un impiego. Ed eccola diventare commessa nel negozio di pasticceria all’angolo della strada.
Com’era bella la mia Anna. Io l’ammiravo incantata. Era piuttosto biondiccia, era alta e magra e soprattutto sorrideva sempre. Non si lamentava mai, neanche quando la vedevo sudare su quel lavatoio infernale a lavare pesanti indumenti e lenzuola in quantità. Le sue mani spesso erano gonfie, ma anche il suo cuore era gonfio di allegria. Io l’ammiravo proprio per questo suo modo di essere e nutrivo per lei tanta tenerezza. Ricordo la sua emozione e la sua ansia quando, dopo il primo giorno di lavoro mi disse:
< Ieri il titolare ha detto che debbo imparare a fare i pacchetti, io non ci sono riuscita troppo bene, non li so fare >.
Le feci vedere io come doveva fare, facemmo allenamento con scatole di diversa grandezza con i fogli del Mattino che la mamma conservava.
Prima di andare al lavoro, ogni giorno passava un minuto da me. Proprio un minutino. Un minutino affinché le mettessi la linea sugli occhi. Il titolare voleva che assumesse un aspetto più presentabile al pubblico, ma lei non aveva tempo per abbellire quel suo volto luminoso e curare le sue gonfie mani. Fino all’ultimo momento doveva sbrigare qualche faccenda e fino all’ultimo momento si sentiva la mamma gridare:
< Muoviti, muoviti, non perdere tempo con questa roba sugli occhi, è tardi, è tardi>.
Io in fretta cercavo di fare la linea diritta e tentavo di fare bene lo stesso spessore su entrambi gli occhi senza sbagliare. Ormai sapevo che quella frase l’avrei risentita il giorno dopo e anche quello successivo.
Col tempo ci sposammo. Perdemmo un poco i contatti, ma quando ci ritrovammo raccontammo ai nostri figli la nostra infanzia, la nostra adolescenza. Lei ricordò le continue richieste del titolare di quella pasticceria. Ricordò però anche che questo titolare le aveva consentito di mangiare tutti i cioccolatini nudi che voleva.
< Tutti, tutti quelli che voglio?>
Mi sembra ancora di sentirla quando lo raccontava sbigottita.
Come era possibile che potesse mangiare tutti i cioccolatini che voleva? Il mistero fu presto svelato. Anna mangiò tanti e tanti di quei cioccolatini che la fecero stare tanto male da non desiderarne più. Non ne avrebbe toccato nemmeno uno anche se l’avessero pagata. Ecco lo scopo dell’allettante invito del furbetto titolare!
Non so se dopo tanto tempo Anna abbia ripreso a mangiare cioccolatini. Ultimamente, dopo un’ulteriore sosta di qualche anno, dovuta a menage, impegni e interessi diversi, ci siamo frequentate nuovamente con gioia. Abbiamo rievocato i momenti lieti e in particolare quando giocavamo con la corda. Dapprima noi due cominciavamo a saltare individualmente. Ci allenavamo saltando stando ferme sul posto, con due piedi o un piede; saltellando di corsa oppure all’indietro. Poi, quando arrivavano le altre ci mettevamo una da un lato e una dall’altro e cominciavamo a saltare a turno con le nostre amiche.
< Arancia, limone e fragola > intonavamo mentre saltavamo.
A ognuna di noi era attribuito il nome di un frutto. Si faceva la conta e cominciava a saltare la prescelta. Quando sbagliava, doveva cedere il posto alla compagna alla quale era stato attribuito il nome del frutto su cui aveva sbagliato.
Fatto sta che, se eravamo in tre: arancia, limone e fragola, il ritmo della filastrocca che pronunciavamo era semplice e orecchiabile, ma quando cominciavano a venire altre compagne, il canto si complicava:
< Arancia, limone, fragola, mandarino, mela e banana >
< No, c’è prima la banana e poi la mela > e così cominciavano discussioni che aumentavano ancora di più quando aggiungevamo: uva, castagna e pera.
A quel punto non si capiva più niente. C’era prima la castagna o l’uva? Chi doveva continuare il gioco? Perché le prime tre avevano sempre lo stesso nome e non dovevano far fatica a ricordare quale frutto fossero? Abitualmente Anna del sarto, Anna del giornalaio ed io cominciavamo sempre per prime il gioco e ci identificavamo sempre con lo stesso frutto. Chi veniva dopo si doveva adattare. Ciò che ho ricordato bene, insieme ad Anna, è che di solito io ero l’arancia e lei era il limone se eravamo fortunate che la mamma non si accorgesse che cominciavamo a giocare. Altre volte, lei era banana e un altro ancora castagna quando, dopo aver finito di sbrigare una faccenda, la mamma le permetteva di sgranchire le gambe con gli ultimi saltelli concessi prima della cena.
In qualsiasi circostanza lei era contenta come sempre e lo era anche quando l’ho rivista fino a qualche anno fa, quando le circostanze della vita ci hanno permesso di ridere insieme, viaggiare e giocare a burraco senza avere il timore di essere interrotte da una voce imperiosa.
Sono state belle le giornate trascorse con lei a Berlino, Firenze e Monaco. Anche se avevamo interessi diversi, lei mi aspettava al bar mentre io andavo a visitare un museo. Comprava un giornale e si trastullava vedendo i turisti procedere avanti a sé mentre sorseggiava e sgranocchiava noccioline e patatine.
Quando le dissi, prima di partire per Berlino, che volevo vedere un campo di concentramento, lei fu felice di trascorrere circa sei ore allo zoo. Fu felice come una bambina quel giorno felice, forse come non lo era mai stata.
Bella la mia Anna, ha recuperato nel tempo la sua infanzia e la sua adolescenza non goduta. Anch’io ho goduto pienamente agli chalet, al cinema, al teatro e in vacanza la sua presenza senza nessuna fretta e ora mi trovo nuovamente sola e senza la sua allegria per un malinteso intercorso fra noi. Lei forse non sa che la penso sempre. Non sa che ho ammirato le sue mani finalmente sgonfie e il leggero trucco che finalmente ha imparato a fare. Non sa che mi manca la sua voce squillante, la sua allegria, l’eterna ricerca di svago e l’incessante voglia di coinvolgere e stare in compagnia ma, sono certa che presto lo saprà.
Ho riscritto così, senza che me ne rendessi conto una pagina di vita dimenticata nello scrigno dei ricordi lieti. Nel farlo mi sono rivista bambina. Nel ricordare, ho riprovato dimenticate emozioni. Mi sono rivista mentre saltavo la corda, il mio gioco preferito. Ho rivisto noi bambine ridere e gioire, ma a un tratto mi sono ritrovata a girare la corda da sola. Con la corda fra le vuote mani, ho concluso che debbo saltare di nuovo e debbo essere io a promuovere il gioco, come spesso facevo.
< Giochiamo ad arancia, limone e fragola?> irromperò radiante quando le telefonerò. Già la vedo felice di ritornare bambina assieme a me.
Grazie, amico mio, mi hai dato l’opportunità di rigiocare con la corda e farla girare insieme ad Anna, la figlia del sarto, s’intende!